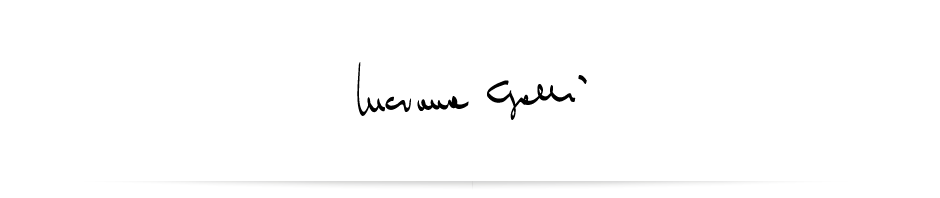LIBRI
BARI NON E’ UNA CITTA’ ITALIANA
QUODLIBET EDITORE 2021
Luciana Galli
Fotografia come scoperta
Roberto Lacarbonara
Prefazione al libro
“Chi ha detto che il mondo è già stato scoperto?”, chiede Gregor, il lisergico protagonista de L’ora del vero sentire di Peter Handke.
Tra conoscere e scoprire non c’è solo una qualità differente di partecipazione alle cose, c’è proprio una contraddizione, un incastro impossibile di azione e memoria, un’eccedenza: ogni scoperta rompe gli argini del quotidiano, irrompe nell’adesso, esonda dal vaso dell’esperienza e allaga il pavimento dove stanno i piedi che ci reggono.
Una fotografia venuta bene – e non c’è scoperta senza la cattura di un’immagine mai vista né attesa, imprevista – ha sempre a che fare con la verità e con le sue contraddizioni. Dovrà invero dire contro – contraddire e tradire – scomodare, spintonare e scoperchiare l’ovvietà lungo la strada (ob-viam), imbattersi nel nuovo che sta lì da sempre ma sempre nascosto, al coperto, invisibile.
Da una cartolina poggiata sottosopra sulla scrivania, Cortázar scopre per la prima volta una città, Bari, e non la riconosce. E allora la inventa, “guardandola sottosopra con gli occhi socchiusi”, la immagina con una “corona marina in alto” e di sotto “infinite celle scintillanti”, quasi un favo o una rete lanciata verso il mare. “Ecco, Hélène, io potrei raccontare così la mia Bari, a testa in giù e ritagliata, su scala diversa”[1].
Ogni volta che Luciana Galli rifà la stessa strada, da decenni – da via Abbrescia al Lungomare di Crollalanza, per tirare dritto fino al centro della città vecchia e da lì per il porto, le spiagge, le tante periferie dell’industria e dei quartieri popolari – si imbatte in quella sorta di straniero che è lo sguardo quando non smette di innamorarsi di qualcuno o di qualcosa. Amore e odio, amore e rancore, amore e rabbia, amore e sberle, amore e scherno: tutte coppie mal assortite di un sentimento vero, che non smette di scoprire le virtù e gli insopportabili difetti di quell’altro che, a sua volta, non sta fermo mai, e non lo puoi affermare o definire, né con una parola né con una fotografia.
Bari che bara
“Bari non è una città italiana”, chiosa lo scrittore argentino, tra lo stupore e una certa rassegnazione. Perché questa città fugge da se stessa, mutandosi di continuo, fingendosi altro rispetto agli stereotipi del sud e a quelli della provincia. “Il mondo nuovo, questa la definizione della città data lungo il corso degli ultimi centocinquant’anni da molti poeti baresi, da Abbrescia a De Fano. Non fai in tempo a girarti, scrivono, che appaiono gru, ponteggi, nuovi edifici e foreste di pilastri” (Nigro)[2].
Eppure Le due Bari, scoperte da Pasolini in una notte del ’51, hanno una irresistibile indefinitezza, tra le “urla di rapaci” che straziano il buio e il “cuore leggero” che anima il mattino di luce chiarissima riverberata dai calcari romanici e dalla calce: “Qui tutto è chiaro”[3]
Il destino di Bari sembra porsi al di là dei binari della storia, come un deragliamento sempre in agguato, scrollandosi di dosso gli arcaismi e la paesanità che pure gli si addicono. E allora guarda a Est – più per levantinismo che per orientalismo – ma soprattutto a Nord, lungo la direttrice Adriatica che da sempre converge su Venezia e sull’Europa intera. “Costantemente abitato dall’impazienza” lo spirito dei baresi “non è paralizzato da un grande passato come quello che si incontra passeggiando per le strade di Napoli e Palermo, non è seduto su una grande tradizione. Città meridionale solo per caso […] Bari bara, finge, imbroglia, bluffa, senza avere nessun punto sulle mani, che la sua modernità è una pura rappresentazione”[4] (Cassano).
Quella volta che re Ferdinando IV aveva acconsentito di far uscire Bari dalla stretta delle mura difensive per ridare un nuovo volto (urbanistico) alla città, il sovversivo napoleonico Murat aveva battezzato l’urbe con la posa della prima pietra e di una ricca gemma (1816), segno di auspicata, danarosa prosperità per la prima città dei commerci transmediterranei. Da quel tempo, tutto un affiorare di audaci architetture sempre un passo oltre l’irregimentata quadratura murattiana, quasi una sfida al reticolo e alla regola, fino a quel 1955, anno di demolizione della “presunta prima casa” per far posto al primo grattacielo. Via tutto, fare spazio: “Durante i lavori di demolizione il sindaco Francesco Chieco farà presidiare il luogo dai vigili urbani per evitare che i soliti ignoti trafugassero la famosa ‘gemma’ di Murat. Ma nonostante le accurate ricerche, non sarà trovato nulla. Neppure la prima pietra. Anche la lapide, che oggi fa bella mostra di sé all’altezza del primo piano del grattacielo, non è l’originale”[5].
Fu deluso anche Calvino quando, rapito e perduto nel labirintico “formicaio” della città vecchia, volle portar via con sé alcune immagini, sorprendenti ricordi: “Cercai all’albergo cartoline di Bari vecchia; dissero che non ne avevano, che i baresi non hanno piacere che si mostri. Capisco. Tutti quei palazzoni moderni del lungomare, quella speranza visibile di grande avvenire, quel sentirsi la perla del Sud o dell’Est d’Italia è come chi si fa ricco e nasconde i suoi vecchi cenci frustati, e i meridionali, si sa, sono nobili orgogliosi”[6].
È da questo scarto, da questa ansiosa fuga in avanti che occorre guardare la città; non tanto come promesse de bonheur della vita moderna, quanto come tentativo di staccata sul passato e di indossare l’abito buono nelle domeniche a venire: maschera e stucco sul fantasma che la agita nel profondo.
Contro la fotografia
Se questa città è senza memoria, un po’ spericolata e assai affarista, pragmatica e a tratti “apolide” – “sembra che Bari non appartenga più a nessuno e che nessuno più appartenga a Bari” – non c’è modo di scoprirla se non “a testa in giù”, come fa lo sprovveduto Cortàzar, com’ è, da una vita, la fotografia di Luciana Galli.
Sei tu che non sei italiana (le dissi tempo fa). – Ma davvero pensi questo? – Ne ho le prove (le risposi).
Quel lungo lavoro della Galli contro la fotografia – contro un’idea stereotipata e manierista del “paesaggio italiano” ancorato attorno a ineludibili stelle fisse (Ghirri) e succedanee costellazioni mobili (epigoni) – sta proprio nell’innesto del sospetto e della superfetazione entro le maglie della cercata metafisica italiana. Il “bisogno di scoprire una normalità delle cose, antieroica, antimitica, quotidiana e non retorica” professata da Gabriele Basilico si coniuga con quella “spectacular form of amnesia”[7] che Galli ritrova nella sua città e che alimenta nei codici di un’estetica fotografica molto poco italiana. I primi scatti realizzati a Brighton nel 1967[8] rivelano lungamente l’ammirazione e l’appropriazione della grammatica angloamericana, secondo una intenzione che proviene dall’amata pittura di Hopper, Hockney e Ruscha, ma forse ancor più nel solco della prosa realista, esatta e sintagmatica degli Hemingway, dei Faulkner, dei Lee Masters giunta sino a Bari con tutto il carico portato sulle spalle dai Laterza e sui pensieri del maggiore interprete e traduttore, Cesare Pavese.
La “cruda saggezza” degli scrittori americani, quella “esotica e tragica schiettezza ch’era il loro destino” (Pavese) subentra elettivamente nelle immagini di Galli, soprattutto in virtù di un’origine e di un’insistenza su una città “senza ironia e senza malinconia”, come diceva lo storico letterario Mario Sansone: “Quello che le manca è la percezione delle sfumature e delle tonalità intermedie”[9]. Più che ironica, la barese Luciana Galli fa suo un inaspettato humor, anzi “quell’iper-humor e Pop humor così caratteristico dell’atmosfera d’America”[10] (Baudrillard).
Non c’è dunque spazio per la vaghezza incantata dei colleghi e conterranei Leone e Garzia, protagonisti – in modo diverso – di quel Viaggio in Italia che dalla via Emilia discende gli Appennini fino all’esperienza barese del 1984[11]. Solitaria e un po’ suscettibile, Galli viaggia da sola, raccogliendo tutti i pezzi incoerenti della città e del mondo, spazi che molti considerano attrattivi a causa di un certo “esotismo dei non-luoghi”, rifigurati sulla scorta di Augé fino allo sfinimento. Tali non-luoghi per la Galli diventano riluoghi, spazi indecisi dove sempre e comunque l’uomo sa radicarsi e rigenerarsi, rimestando il nuovo che avanza con gli avanzi del vecchio.
Il “paesaggio ibrido” (Zardini) e contaminato degli anni post-boom non ammette soltanto una critica pur schietta e risoluta; vi è invece posto per tanta ilarità, bonaria derisione, come negli scatti sull’architettura e sulla costa adriatica. Un’allitterazione formale e visuale che dà luogo a un’estetica dell’ostacolo, del promiscuo, della commistione improbabile tra uomini e cose, tra la storia e le storie, tra il neolitico e l’acciaio, come nelle architetture degli archistar Chiaia-Napolitano, gli “americani di Bari”[12] che hanno rinnovato il volto del capoluogo pugliese negli anni ‘70 e ‘80. Oppure come – stavolta senza la minima ironia! – Cesare Brandi denunciava in quegli anni quando, pellegrino di Puglia, si imbatte in una regione che “a pochi passi da Bari, proprio sulla strada asfaltata, issa un menhir e, accanto, un cartellone pubblicitario. Ciò che è più che un simbolo di quello che la Puglia è; e di quello che Bari vuole essere”[13].
Stupisce poi che lo sguardo della Galli non conosca mutamenti lungo la corsa del tempo, scansando ad esempio gli avvicendamenti stilistici della trimurti reportage-paesaggio-documento con cui molta fotografia italiana viene a patti nel trentennio che chiude il secolo scorso. Per Galli, già il mondo in bianco e nero era inseminato di quegli “ibridi” mostruosi e paradossali, tanto nel costume quanto nei luoghi; gli stessi che ci straniscono nella meravigliosa Città invasa che nel 1978 Salbitani documenta ancora in bicromia, accumulando “indizi di una meta-città dominata da cartelloni pubblicitari, locandine cinematografiche, automobili, manichini, passanti spesso non distinguibili dalle loro controfigure”[14]. “Contraddittorie domande” (Cacciari) necessitano di fronte alla Città infinita capace di essere ad un tempo madre e macchina, dimora e funzione[15].
Nei dieci anni che precedono la grande rivoluzione fotografica di New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape – l’indimenticata mostra curata da William Jenkins presso la George Eastman House di Rochester (New York) nel 1975, in cui Adams, Baltz, Deal, Gohlke, Nixon, Schott, Shore e Wessel, insieme con i soli europei Bernd e Hilla Becher reinventano la storia del paesaggio e delle sue contaminazioni man-altered (ricordando che il solo Stephen Shore lavora a colori) – Galli ha maturato il proprio disincanto, raccontato le incoerenze della nascente città-collage, aggirandosi con scaltrezza nella “foresta di disturbi visivi”[16] (Frongia) che diventano i veri protagonisti di una fotografia attenta alle geometrie compositive, alle archi-texture più moderne, e che diventeranno persino virtuali e digitali, come nella cattura di immagini da z sul muro fronte-casa in tempi di Covid.
Nelle immagini di Galli anche il colore è colonia di altra terra: artificiale-acido-fluo-fosforescente o elettrico e stridente da ogni cosa, mischiato con le insegne della festa (San Nicola) o addosso alle tante superfici di cantieri, cartelloni, vetrine, muraglioni. Un colore che la fotografa rintraccia nelle profondità popolane della città vecchia, dei porti, del folklore, del rito: tanti tropi di un luogo che ha inventato il kitsch prima ancora del pop.
Il tutto converge in più occasioni in una vista che ha a che fare con la svista, con l’errore, con la parte di realtà fuggita al controllo della coerenza e dell’ordine: ne vien fuori un immenso, indistinto trompe l’oeil che, come trappola per gli occhi, insinua il dubbio tra il vero ed il falso, quando è invece tutto vero. Ha amato, Galli, il ritmo delle immagini di Cuchi White, quel gioco a quattro mani con Perec – L’oeil ébloui (1987) – e la volontà di confondersi con gli oggetti rappresentati, tra illusioni ottiche ed inciampi della strada, del paesaggio, della logica. Mettere in scena la parodia della teatralità, la “retorica della spazialità fittizia” (Perec), recuperando indizi e tracce non tanto della realtà quanto di una sua verosimiglianza, “un déjà vu eppure dimenticato”[17].
Nella indecidibilità tra ciò che si vede e ciò che è, ritorna il piacere spassoso della scoperta, come fa il bambino alle prese con lo specchio, cercando di rimettere al posto la destra e la sinistra, l’inizio e la fine di una stanza o di un’immagine. Così Luciana Galli esplora le défaillance di una città intenta a rifarsi il look giorno dopo giorno, per non vedersi vecchia e malandata, finendo per mettere in campo un frankenstein reloaded del gusto e del disgusto.
Era questa in fondo la grande lezione di Walker Evans, il maestro di tutti, l’“occhio democratico” che mette ogni cosa sullo stesso piano cercando di registrare ciò che indifferentemente si può cogliere dalla finestra di casa o all’incrocio di una strada: spesso alcuni anonimi frammenti compongono il vero nome di un luogo, lo identificano, lo connotano ben più di un monumento o di una targa votiva.
Invece non tutti accettavano, sul finire degli anni ’80, la spregiudicatezza dei Dialectical Landscape nella mostra Nuovo Paesaggio Americano: Ghirri intravedeva un “iperrealismo disumanizzato” e una “anestesia dello sguardo per eccesso di descrizione”[18]; ma erano proprio queste accelerazioni a toglierci dagli occhi quella forma edulcorata di immaginazione che all’epoca sembrava privilegiare un certo letargo rispetto alla fotografia netta e spigliata degli americani o di pochi altri indipendenti. Tra questi, con Galli, c’è forse solo William Guerrieri, uno dei rari punti di congiunzione tra una teoria diafana e tonalista del colore mediterraneo e la mazzetta timbrico-pantone di quello atlantico: “l’esasperata esattezza delle immagini si risolveva in una critica piuttosto che in una adesione all’estetica del paesaggio rappresentato […] in aperto contrasto con il disegno lineare dei materiali sintetici”[19].
Soltanto la realtà
Ebbene, non c’è niente di “disumano” in queste immagini. Sì, forse a volte non c’è poesia, o ce n’è di diversa, più cinica e caustica. Leggete per esempio Ceronetti ed il “suo” Viaggio in Italia del 1983, un anno prima – e forse un anno luce – rispetto ai fotografi italiani. Giulio Einaudi lo aveva letteralmente spedito per le strade del Belpaese con tutta quella sua indignazione satirica da piemontese. E tra città grandi e piccole, tra provincie, monumenti, musei, ma anche carceri, cimiteri e manicomi, Ceronetti scrive di manifesti affissi su muri imbrattati, insegne di negozi, traffico scapigliato mentre passa in rassegna tante risibili volgarità di quel caos felice ed infelice che è l’Italia di quegli anni. E alla fine giunge a Bari (nel 1990) dove il poeta perde completamente le staffe e con queste parole descrive un mondo sconcertante, davvero fuori da ogni crisma.
Bari, un triste scarafaggiaio di auto e moto, tra ciuffi torvi di canaglie appesi ai muri in vicinanza di bar e pizzerie che al passaggio di una faccia pensosa si esercitano in sghignazzamenti, fischi, rutti, strida, insulti. […] Mi avvertono che Bari è peggio di ogni altro luogo (a me brucia Trani), salvo Taranto dove l’enorme bordello siderurgico ha permesso, alla voglia diffusa di peccare contro la legge, di scaricarsi senza ritegno.“Stia attento: strappano di mano qualsiasi cosa, anche un giornale, un cartoccio di olive, una bottiglia, un maccherone crudo…”.
Ho una nuova borsa, per forza, ma talmente brutta che spero mi sia rubata. La porterò con negligenza nei quartieri più avventurosi.
Ingeneroso, per carità! Che ti hanno fatto, Ceronetti? Dov’è finito quel “diamante che riga il vetro del cielo” (Cangiullo), quella città “tra le più vive del Sud dal punto di vista culturale” (Calvino) e quel popolo “tanto fine e colto e dotato di un intuito sorprendente” che aveva rapito il cuore di Giacomo Puccini al punto da ritenerla “quasi una seconda patria”?
Tuttavia se – come ammette sorridente Pasolini – “i baresi si divertono a vivere”, forse sapranno anche sorridere delle maldicenze dei poeti o del sarcasmo delle immagini. Che hanno il vizio di scoprire un po’ le carte, di scomodare vizi e contraddizioni. Altrimenti non sarebbe poesia o fotografia. Sarebbe soltanto la realtà.
[1] Julio Cortázar, Componibile 62, 1968; trad. it. Id., Einaudi, Torino 1974.
[2] Raffaele Nigro, Assedio di mare con mercanti, testo inedito per Luciana Galli.
[3] Pier Paolo Pasolini, Le due Bari, in “Il Popolo”, Roma 8 agosto 1951.
[4] Franco Cassano, Mal di Levante, Laterza, Bari 1997.
[5] Nicola Mascellaro, C’era una volta Bari, LB Edizioni, Bari 2019 .
[6] Italo Calvino, Franco Antonicelli (a cura di), Finibusterre, Besa ed., Nardò 1999.
[7] Neville Wakefield, Ed Ruscha: New paintings and a retrospective of works on paper, d,Offay, Londra 1988
[8] Cfr. Roberto Lacarbonara (a cura di), Luciana Galli. Fotografie 1967-2016, Skira, Milano 2016.
[9] Cfr. Franco Cassano, op. cit.
[10] Jean Baudrillard, America, 1988; trad it. Id, SE, Milano 2000.
[11] Nel 1984 Luigi Ghirri, Gianni Leone ed Enzo Velati concepiscono uno straordinario progetto di “rifondazione” dell’immagine del paesaggio italiano. Il progetto “Viaggio in Italia” prende forma in una mostra alla Pinacoteca Provinciale di Bari e in un libro pubblicato dal Quadrante di Alessandria, con un testo di Arturo Carlo Quintavalle e uno scritto di Gianni Celati.
[12] Negi anni Cinquanta gli “americani di Bari”, così come vengono definiti da Bruno Zevi, realizzano oltre 35 costruzioni nel capoluogo barese, facendo ricorso a tecniche e materiali innovativi come il curtain wall in raccordo con la pietra pugliese con apparati decorativi realizzati da maestranze locali. Luciana Galli vive in uno degli edifici progettati dal duo Chiaia-Napolitano.
[13] Cesare Brandi, Pellegrino di Puglia, Laterza, Bari 1977.
[14] Antonello Frongia, Il luogo e la scena: la città come testo fotografico, in Roberta Valtorta (a cura di), Luogo e identità nella fotografia italiana contemporanea, Einaudi, Torino 2013.
[15] Massimo Cacciari, Nomadi in prigione, in Aldo Bonomi, Alberto Abruzzese (a cura di), La città infinita, Bruno Mondadori, Milano 2004.
[16] Antonello Frongia, op. cit.
[17] Georges Perec, Cuchi White, L’oeil ébloui, Éditions du Chêne, Parigi 1981.
[18] Luigi Ghirri, Niente di antico sotto il sole. Scritti e immagini per un’autobiografia, SEI, Torino 1997.
[19] Antonello Frongia, op. cit.
BARI NON E’ UNA CITTA’ ITALIANA
QUODLIBET EDITORE 2021
Giorgio Vasta
Prefazione al libro
Bari muta
La foto habla
Bari cambia, recita la scritta bianca che si staglia contro un cielo di cirri setosi sotto il quale si allunga l’azzurro quieto del mare: al di là di questo banner pubblicitario, un frammento del Teatro Margherita; al di qua, perplesso nella postura e nella direzione dello sguardo celato dagli occhiali scuri, un uomo che passa.La foto che inaugura il percorso di Luciana Galli attraverso Bari vale da punto di coagulo di ciò che succede nei suoi scatti: nel suo modo di guardare. Perché prima ancora dello spazio, del tempo e della macchina fotografica, ci sono gli occhi. Che, seguendo Julio Cortázar, non devono essere del tutto aperti: Bari, infatti, si vede meglio riducendo l’ampiezza, contraendo la prospettiva: socchiudendo – come Noodles alla fine di C’era una volta in America, quando nella fumeria d’oppio, per prendere congedo dalla storia della sua vita, stringe gli occhi, sorride, ci guarda e di colpo tutto si fa terso e si rivela.
La Bari che cade – e accade – negli occhi di Luciana Galli è strategicamente corpuscolare, è un catalogo di particelle, un succedersi di frammenti che individuano e insieme disorientano. È Bari, certo, osservata in quelli che sono i suoi emblemi e nei suoi margini – e finalmente riconosciuta fuori dalla logica tradizionale del decoro o del degrado –, ma è anche un costante interrogarsi su che cos’è oggi una città.
Bari – dice lo sguardo di Luciana Galli – è escogitazione e collaudo di progetti virtuosi e durevoli così come di inciampi e arresti altrettanto duraturi; di intenzioni lucide e determinate e di frustrazioni che a volte si risolvono in rassegnazioni (perché forse la morfologia di Bari – la morfologia di una città – è l’esito del mescolarsi di propositi e fallimenti, di operosità e di inerzia). Lungo questa traccia, Luciana Galli percorre Bari osservando lo spazio – e il tempo che, imprimendosi nello spazio, si fa nitido e si lascia leggere – e ogni suo sguardo inventa la città. Ciò che c’è, ogni fenomeno, è disidentico: è quello che è, ed è altro. Un chioschetto della Coca Cola è anche un’astronave di un rosso e di un bianco smaglianti delicatamente deposta su un pavimento a scacchi; uno stoccaggio di bottigliette di Coca Cola e Fanta è un archivio a cielo aperto – di vetro, di vuoti; le linee di luce – segmenti, angoli, fulmini, zig-zag – che scorrono sulle pareti del nuovo sottopasso della stazione trasformano il presente in futuro.
Soprattutto, lo sguardo riconosce – lo sguardo desidera – le pure forme, così perentorie da rendere il contesto secondario: gli spigoli vivi, le scalanature, gli aggetti di cemento, le barriere rettilinee, e il curvilineo che – concavo o convesso, continuo o traforato – si introduce sensuale nello spazio urbano sotto forma di circoli, oblò, sfere, dischi, pianeti – le diverse possibili declinazioni del rotondo e del globoso: nel 2018 un’aureola bianca raggiata in cui si inscrive la nuca bianca del Generale Armando Diaz che, di spalle, contempla i divertimenti della ruota panoramica, oppure – è il 1992 – l’oculare del mirino di una macchina fotografica coincidente con un varco circolare nella cupola del Teatro Petruzzelli dopo l’incendio dell’anno prima: le ghiere rosso mattone, i cerchi di ferro che spuntano dalla pietra, un’altra nuca – quella di Apollo – perfettamente centrata nel mirino; ancora, al porto, le bobine di ferro, funi di ruggine conservate in miriadi di spire.
Osservando i suoi scatti ci rendiamo conto che lo sguardo di Luciana Galli è un picaro. Non si avventura nella Spagna del Siglo de Oro ma lungo quella superficie strutturalmente incerta, alonare, che si chiama Bari. Girovagando, il picaro scruta, stabilisce nessi, comprende, inventa legami: coglie – come si dice – le differenze. Studia la metamorfosi. Tanto i processi trasformativi pianificati, quanto il naturale disgregarsi della materia: come Bari – smontandosi, rimontandosi, smontandosi ancora – cambia. Quando nel 1989 viene edificato lo Stadio San Nicola, il picaro vede un gatto che si aggira nei pressi della gabbia toracica di un capodoglio in costruzione, per poi concentrarsi sulle chele arcuate delle benne – un ragno di Louise Bourgeois –, uno stormo che gli si scompiglia sfocato intorno. Ancora un andare, un ritornare – per il picaro l’andirivieni non ha a che fare con lo smarrimento o l’impazienza: è una tecnica, un modo di stare nello spazio – e lo sguardo annota come la passerella pedonale di viale Imperatore Traiano abbia modificato nell’arco di due anni la sua fisionomia (pur mantenendo una specie di peculiare vocazione al graticcio). Sempre calibratamente vagabondando, il picaro incontra tutto ciò che a Bari è introdotto e qualificato dalla preposizione latina ex: la raffineria Stanic, lo stabilimento Fibronit, la centrale termoelettrica Enel, il macello comunale, la caserma Rossani, la manifattura tabacchi: da ognuno di questi spazi trapela un senso di fierezza, l’orgoglio aspro dell’abbandono: la sensazione è che questi luoghi sappiano qualcosa che nessun altro sa, ma non possono parlare – e ciò che sanno, qualora potessero parlare, non è ascoltabile. E così, in un continuo stupore – sempre sobrio – al cospetto delle forme che accadono, il picaro raggiunge quel punto (quell’istante) dove in corso Italia – forse è il primo pomeriggio, quando non passa nessuno e le infestanti sbucano tenaci dalle spaccature dell’asfalto – Bari se ne sta sola (sola e sempre, si dice, ma forse in questo caso è più esatto sola è sempre). Fissa. Impalata. E tace.
Bari cambia: Bari muta.
Muta, sì, ma «la foto habla», come afferma Luciana Galli in un’intervista di qualche anno fa a Roberto Lacarbonara. La foto entra nel silenzio dello spazio e del tempo, e li rende udibili: li fa parlare. Un silenzio multicolore davanti al quale lo sguardo rallenta, si ferma, contempla, è quello dei fondali. La Bari di Luciana Galli è una città che moltiplica i propri piani di esistenza, mettendo di continuo in relazione edifici, strade, piazze, ponti – tutto ciò che è tradizionalmente e logicamente statico – con la rappresentazione unidimensionale ed euforica dello spazio: banner come quello lungo il quale si muove diffidente l’uomo con gli occhiali scuri, allestimenti, mock up, trompe-l’œil, vetrofanie, murales, scene: fondali, appunto, che però tutt’altro che starsene sullo sfondo avanzano, si appostano, si proiettano verso lo sguardo generando una combinazione di costruzioni originali (quanto splendidamente enigmatico diventa adesso questo aggettivo) e di apparati effimeri. A Bari, dunque, il fittizio è reale, e la città esiste anche attraverso l’impulso continuo a scenografarsi, in un equilibrio sottile – che in un certo senso è una forma di involontaria autoironia – tra ciò che è stabile e ciò che è transitorio, tra le strutture gravi in presunto dialogo con l’eterno, e il fugace, il faceto: una labilità caparbiamente gioiosa che si innesca soprattutto laddove fervono – o riposano – i lavori in corso, i rifacimenti, i restauri, i ripristini; dove lo spazio urbano si rompe, la fascia che lo avvolge è un dipinto o una forma plastica: una benda teatrale.
In questa Bari molteplice e naturalmente ambigua – dove anche la fotografa si scompone riverberando nei riflessi delle vetrine – il picaro osserva chi la città la abita, affollandosi in moltitudini coriandolari durante le feste, le inaugurazioni, il Pride, le fiere, oppure percorrendola isolato: chi nel 1976 si china a raccogliere le granaglie insaccate nel cellophane e chi dieci anni dopo trasporta quegli stessi sacchi sulla testa (in che direzione si muove il tempo a Bari?, ci si chiede guardando), chi a pranzo ripara all’ombra delle tende e chi morde il tentacolo di un polpo – il boccolo chitinoso, le ventose dilatate; chi di spalle si inoltra nella spiaggia di una Bari Copacabana – sullo sfondo le palme alte e sottili, in primo piano lo stelo curvo di un microfono, una bottiglia di plastica tagliata – e chi, sempre di spalle, si protegge dal sole sotto un cappello-ombrello variopinto; e quei due bambini rossi: lei, nel 2017, seduta sulle spalle del padre a contemplare le Frecce Tricolore; un anno dopo lui – solo lo scheletro bianco delle luminarie a fargli compagnia – semplicemente sorge, bucando il vuoto celeste.
Ed ecco allora, e infine, cos’è Bari – la città muta, mutante – nello sguardo di Luciana Galli. Un album di aria e di acqua. Una teoria di azzurri, di blu, di celesti. Una fabbrica di luce. Un censimento di che cosa può essere, in quel punto dell’Adriatico, il mare – ordinato tra le banchine e i piloni del porto oppure geometricamente perduto (quel mare che più lo guardi più si ritrae), il mare pomeridiano fatto di acqua e di ombre o il mare di crespe e piegoline – qualche barca, una canoa, lo spettro circolare della ruota panoramica che si disegna sull’acqua –, fino al mare lungomare teoricamente docile, in realtà una lastra di buio – e un censimento di che cosa può essere il cielo: quello turchese, il cobalto, il cielo elettrico o color polvere; la luce composita che si struttura dopo la pioggia intagliando ogni forma del paesaggio, la luce che rende lo spazio fiordaliso; un cielo di nuvole nel quale un biplano fa penetrare la scrittura, così come il cielo che cade giù nel verdino dei secchi incrostati su un moletto, nei catini di plastica blu attraversati dalla radiazione luminosa – ogni catino una detonazione di colore – fino a quel brulicare di celeste vernice che punta il rosso di uno scafo rovesciato.
Se Bari cambia – se Bari muta – il picaro distoglie lo sguardo dal mutevole e fissa l’invariare, ciò che attraverso le epoche permane inalterabile: la materia del cielo e del mare che ignara e limpidamente ottusa si ostina a continuare, estranea a ogni progetto, alla tensione in avanti, al mito del futuro; a ogni sorte: magnifica, progressiva, involuta o mortificante; perché la materia del cielo e del mare non sa nulla delle epoche, è un’analfabeta dei secoli (e nei secoli): serenamente refrattaria, se ne sta lì, qui, ubiqua, diacronica. Ferma. Laconica, se non del tutto silenziosa.
E dunque. Il picaro socchiude gli occhi. Nel suo sguardo, la città muta si illumina di una tenerezza severa.
La foto habla.Tra il cielo e il mare, Bari si nutre ancora del celeste e dell’azzurro.
LUCIANA GALLI FOTOGRAFIE 1967-2016.
SKIRA EDITORE 2016
Roberto Lacarbonara
Prefazione al libro
Da lontano
Nel corso del convegno di studi semiotici La fotografia: oggetto teorico e pratica sociale1 (Roma, 2010), chiamato a intervenire sulla dilagante pratica della fotografia digitale e della sua pervasività collettiva, Umberto Eco ammette una certa “colpevolezza autoriale”, ovvero l’istinto – vissuto in prima persona nel corso di qualche viaggio – di provarsi come autore, fotografo e reporter, in grado di documentare un’esperienza concreta con centinaia di immagini di rapida cattura. Ma ben presto, di ritorno a casa, la sconcertante consapevolezza: “Naturalmente mi ero portato dietro una macchina fotografica e avevo fotografato tutto, incessantemente. Le foto sono orribili, non mi servono e non mi sono mai servite, ho piuttosto comperato dei libri dove c’erano foto migliori, e di quel viaggio non ricordo più niente. Ero troppo occupato a fotografare e non ho guardato. Da quel giorno non ho mai più fatto fotografie in vita mia, partendo dal principio che ci sarebbe sempre stato qualcuno che le faceva al posto mio”.
Questo affabile J’accuse che il semiologo italiano rivolge a se stesso e alla platea degli auditori è una delle sintesi più lucide all’interno di un’ampia letteratura critica ed estetica sulla diffusione della pratica fotografica. Ma la questione posta è doppia: da un lato Eco sottolinea un “eccesso di possibilità fotografica” – e il consistente, rapido e immediato accesso a tale istanza favorito dalle tecnologie dei media digitali -, dall’altro rimarca la sovraesposizione cui ogni individuo è sottoposto nei confronti delle immagini grafiche e fotografiche e della loro ubiqua presenza. Un eccesso che satura lo spazio sociale (reale e virtuale) con foto in grado di mediare la nostra visione, di dirci cosa e come vedere, di guardare al nostro posto.
È così che il mondo costruisce la propria visione del mondo; così la realtà convive, sempre più spesso, con le sue stesse invadenti rappresentazioni. Ed è esattamente a questa compresenza di cose e di fantasmi che da sempre Luciana Galli guarda.
Tra gli autori più consapevoli e critici del processo di trasformazione dell’industria culturale e della società di massa, la fotografa pugliese ha attraversato gli ultimi cinquant’anni di ricerca documentando, con grande ironia e spigliata vivacità compositiva, contesti urbani e linguaggi estetici di società molto diverse e distanti, cogliendo sia gli idiomi e gli stereotipi culturali, sia la progressiva, rapida omologazione del sapere, del gusto e, talvolta, del cattivo gusto all’interno delle metropoli postmoderne.
A partire da un’assolata Brighton del 1967, in quella costa meridionale che accoglie le mete vacanziere della borghesia londinese, la Galli sperimenta un modello di osservazione e composizione che caratterizzerà i decenni successivi. La ricerca è primariamente rivolta alla specificità dei soggetti: non persone ma personaggi, ruoli, apparentemente inconsapevoli, che indossano abiti, codici e modi di comportamento stereotipati. Immerse nel verde di un campo di bocce, due donne eleganti meditano sugli schemi di gioco. La figura centrale divide in due lo spazio, mentre la seconda, a sinistra, dirige il movimento, accompagna lo sguardo con ricercata postura del braccio e curva della schiena. All’orizzonte, un gruppo sparso di altri “attori”, benvestiti, ben ritmati, intenti a disporsi sul green, o assopiti su spiaggine isolate dagli sguardi e dal rito del gioco.
Inoltre, ulteriore cifra nell’ottica di Galli, il punto d’osservazione è già posteriore, a debita distanza, partecipe e discreto, seppur sempre allineato e assonometrico. Uno sguardo che descrive, analizza, s’imbatte in una società colta nel momento di consumare il proprio tempo libero, con delle regole che appartengono tanto al gioco sportivo, quanto a quello sociale.
Da questo momento in avanti, la vicenda fotografica di Luciana Galli precorre una cospicua tradizione di raffinate analisi visive, fotografiche e cinematografiche, orientate alla descrizione delle dinamiche pop e di una “storia del gusto” proprie delle classi medie. Una ricerca che affianca quella di Antonioni e Ferreri, che guarda alla tradizione popolare di Pasolini, Moravia e Calvino, senza mai cedere tuttavia a estetizzazioni moralistiche o alle connotazioni del Neorealismo, ma con una certa predilezione per il grottesco, per una divertita indagine sulle stravaganze e sull’innocente goffaggine della vita quotidiana.
I viaggi in Gran Bretagna e quelli in Crimea (Yalta, 1972), tra la fine degli anni sessanta e i primi settanta, affiancati alla costante perlustrazione della sua terra d’origine, Bari, danno a Galli l’opportunità di costruire confronti e nessi che oggi, a distanza di tempo, appaiono molto significativi rispetto a quella costruzione dell’identità collettiva di cui si è detto. Osservando i luoghi comuni delle relazioni umane, l’autrice inizia a conferire una forma visiva a quello che la sociologia in quegli anni definiva “La realtà come costruzione sociale”, secondo il memorabile saggio di Peter Ludwig Berger e Thomas Luckmann del 19662. Raccontare i “fatti sociali come cose”3, osservare come i modelli culturali diventano man mano impliciti e ordinari tramutandosi in linguaggio – senza l’esigenza di una verifica ma con l’accettazione tacita di modi e prassi – è un approccio di grande valenza critica, capace di scrutare in profondità i “modelli prefabbricati” attraverso cui lo spazio d’esistenza diventa luogo, storia,habitus.
Le prime fotografie in bianco e nero proposte in questo volume colgono un aspetto lirico e aneddotico del costume popolare, specie nella Bari Vecchia così lungamente percorsa dalla Nostra. È il racconto di vite e mestieri esibiti nel loro genere: le donne alle prese con la cura della casa, gli uomini impegnati tra le messi, i bambini persi tra le strade, i giovani raggruppati in discussioni e gli anziani sui sagrati delle chiese, specie “la donna nel nero nel lutto di sempre” cantata da Gaetano nel ’744.
Ben presto però l’immagine s’imbatte in una complessità avvincente, quella del colore, in cui ancora una volta il territorio di partenza è la cultura popolare. In questa direzione, Luciana Galli mostra in pieno la forza innovatrice della propria ricerca. La scena collettiva delle processioni per San Nicola o di madonne trasportate su un cassonato lungo strade sterrate di campagna, “la siesta di pellegrini sotto gli alberi, 1976, che sa di Grande Jatte, il celebre quadro di Seurat”5 e i mercatini assemblati tra icone sacre e icone pop (San Nicola, Marilyn e qualche pagina osé fermata sulle griglie in ferro con mollette di legno) testimoniano il progressivo trasferimento del colore dalle superfici patinate delle comunicazioni pubblicitarie e dalle immagini della vita quotidiana a quelle di una fotografia sempre più capace di incalzare il linguaggio e di raccontare il tempo.
Di lì a pochi anni la Galli compie un passo oltre, allineandosi a una ricerca ben più lontana dal contesto mediterraneo, frutto dell’appassionato sguardo da sempre gettato oltre i confini. Si tratta di un’interrogazione rivolta alle strutture, al colore, alle forme presenti negli ambienti di vita. La grande passione verso Edward Hopper, la matrice americana del colore di William Eggleston e Stephen Shore, insieme a un singolarissimo interesse verso tutti quei fenomeni di convivenza tra realtà e simulazione (dove gli apparati pubblicitari prendono il sopravvento sulle superfici degli spazi pubblici) rendono la fotografia di Galli radicalmente innovativa.
Attraverso un utilizzo molto contrastato e luminoso del colore inizia a osservare i fenomeni del gusto collettivo (dai vestiti ai marchi, dagli oggetti di uso comune e domestico a quelli di svago) e dei comportamenti riconducibili alla working class. Le continue incursioni nella sfera dell’ordinario e del trash portano presto a uno svuotamento dell’immagine dalle presenze umane per divenire pura esibizione di merci, feticci, simboli smaniosi di occupare spazio.
In modo ancora più insidioso rispetto alla “facile” ironia dei colleghi d’oltralpe, spesso rapiti dalla sovrabbondanza icastica di corpi ed espressioni di bizzarri soggetti colti in luoghi pubblici (si pensi alle spiagge di Martin Parr e alla street photography di Harry Gruyaert), Galli si concentra su eccessi comunicativi e ipergrafici con cui il capitalismo va costruendo la realtà, quasi nel tentativo di “vetrinizzare” lo spazio urbano in un tutto indistinto. La fotografa punta l’obiettivo su quella seconda pelle fatta di apparenza che si sostituisce al reale. Il look degli oggetti fotografati e delle superfici artificiali definisce un’estetica metonimica, fatta di tante verosimili sostituzioni, alla stregua di trompe-l’œil sintetici che ingannano e coprono lo spazio pubblico.
Osserviamo in questo modo l’ossessione della nostra società di “abbellire” continuamente palazzi privati, cantieri, edifici pubblici. Rivelando la stupidità e l’inutilità di questi impianti artificiali, Galli moltiplica all’infinito il finzionalismo di adleriana memoria6, partendo dal mondo reale e giocando con i codici del mondo pubblicitario alla ricerca di quel “senso comune che rivela il paradosso dell’orribile ma rassicurante familiarità”7.
L’artista, perdendosi nella folla alla maniera di Allan Poe, dimettendo ogni soggettivismo a favore della sempre più ardita testimonianza indessicale, ci propone nuove “ipoicone” (tornando al suggerimento di Umberto Eco), ovvero immagini in grado di surrogare stimoli reali tramite buone approssimazioni o “miracoli di realismo” di natura illusoria: “Lo stimolo surrogato mi impedisce di
vedere (o sentire) dal punto di vista della mia soggettività, intesa come la mia corporalità; delle cose mi dà un solo profilo, non la molteplicità dei profili che la percezione attuale mi offrirebbe”8.
La grande presenza di “sostituzioni artificiali” nelle fotografie in catalogo trova un centro simbolico nel grande banner in pvc di Berlino 2008. Questa volta il sarcasmo dell’autrice si svela massimamente in virtù di una scena affollata e, al tempo stesso, deserta. L’immagine di numerosi avventori, tutti distinti nella loro estrazione culturale – e messi in posa all’uscita di un treno metropolitano -, è un’assurda mise en abyme degna del peggior scenografo di provincia. Il telo che nasconde un cantiere (a sua volta destinato alla realizzazione di una metropolitana reale) è una coperta troppo corta se solo si indietreggia a sufficienza per gettare lo sguardo su quei container, cavi e barili posti sul retro: così geometrici e ordinati da risultare troppo interessanti per restare celati oltre l’affissione stampata. Nel disperato tentativo di rendere i luoghi comunicabili e rassicuranti, la città si trasforma in un baraccone sguaiato, organizzandosi in maniera barocca come fosse una scena teatrale e declinando il tentativo postmodernista di diffusione dei modelli estetici nello spazio pubblico, in un’alienante corrosione del mondo reale.
Ma la Galli indugia ancora in questa analisi. Aspettando che lo spazio si svuoti di presenze concrete, raggiunge un altro livello di lettura, assai pregnante nel suo stile d’osservazione. Riconosce cioè l’impietosa verità di Borges che, in Elogio dell’ombra(1969), così scrutava la vita propria degli oggetti: “Dureranno più in là del nostro oblio; non sapran mai che ce ne siamo andati”.
In effetti, a ben guardare in tutta l’opera di Galli emerge con evidenza l’approccio anestetico della sua fotografia. È una vera e propria sostituzione dell’attimo decisivo bressoniano con il momento intempestivo dello scatto. L’artista attende lo svuotamento della scena, l’apparire esclusivo della quinta posteriore. Queste immagini e questi oggetti, che sopravvivono al nostro passaggio, indicano alla Galli la direzione dell’intera ricerca, tra l’attitudine documentarista e quella prettamente artistica: mostrare come la gente assegna un posto alle cose ma, anche, come sono le cose quando ce ne allontaniamo; cosa fanno, come cambiano aspetto e colore, che vita hanno quando diamo loro le spalle.
Nei pressi della coeva letteratura americana, la scrittura fotografica si fa storia di inquietante normalità. Sono i Sogni di Raymond Carver, le cronache di Ernest Hemingway, il Tentativo di esaurimento di un luogo parigino di Georges Perec a riempire – o svuotare – il frame della rappresentazione. Non dunque il realismo d’impegno o la narrazione sublime, bensì un’immagine molto più vicina a quell’American Scene con forme di “precisionismo” e illusione di realtà, che la Galli ama in quanto assidua e metodica viaggiatrice in cerca di segni.
Man mano che gli oggetti diventano dominanti e protagonisti, la foto si riempie delle loro stesse strutture scheletriche, a volte caotiche, altre volte ragionate e ossessive. Non l’interesse astratto verso la geometria, quanto piuttosto la costante giustapposizione di membrane visive alimenta molte immagini dei primi anni 2000. Sono griglie a volte asettiche come in Andreas Gursky o Matthias Hoch, ma molto più spesso assolvono a quella onnipresente “distanziazione” voluta dall’artista. Veri e propri filtri-recettori, geometrie colorate o metalliche che esprimono ancora una volta il modo in cui le cose si incastrano e, allo stesso tempo, si intromettono nel paesaggio visivo. Sono griglie a volte deboli e precarie, altre volte invasive e prominenti, ma accomunate dalla comune tendenza a spazializzarsi, a uscire dal frame per proseguire ben oltre, diventando il vero paesaggio infinito al di qua del vanishing point di prospettiva.
La conquista della distanza, maturata nel tempo, induce l’autrice a viaggiare nel mondo sulla scorta di posizionamenti sempre più reconditi rispetto alla scena pubblica. Tra il voyeurismo e il paradigma indiziario, Galli si muove da Cuba agli Emirati scrutando i modi in cui le città conservano tenacemente i propri codici nonostante la globalizzazione dei modelli estetici e tecnologici. Gli arabi sono forse i soggetti che, con maggiore evidenza, incorporano i contrasti metamorfici in corso. Del resto, città come Doha, Dubai o Abu Dhabi mostrano costantemente la propria inautenticità: sono la forma più lampante di come reinventare uno spazio possa anche significare reinventare una tradizione e un popolo. E anche in questo caso Galli sceglie di osservare dalle spalle, oppure stando al di qua di una vetrina, di un cancello o di una griglia/filtro architettonico: la distanza è conservata, l’altro è colto nella sua paradossale – e forse impossibile – spontaneità.
È un aspetto che torna in modo ben diverso, ma con medesima efficacia, anche quando la fotografia diventa riproduzione anaforica del passato, ovvero quando, a farsi distanti, sono i reperti del tempo. Nelle immagini acquisite nel museo della Fondazione Prada (Milano, 2015) o nel sito archeologico di Butrinto (2009) la fotografia dimostra pienamente il potere evocativo e comunicativo delle opere d’arte. Nel mostrarci i luoghi e i meccanismi dell’esposizione, Galli indugia sul carattere manipolatorio del dispositivo museale, la pretesa di iconicità da parte dei curatori. In questo senso, ci supporta il significato etimologico della parola “allestimento”, dal francese lester, zavorra, àncora: esibire la cultura vuol dire ancorarla e incorniciarla entro un codice comunicativo, rendendola, per questo, finzione.
Infine, non è affatto casuale la totale assenza di ritratti nell’ambito di questa breve ricognizione. Rarissimi gli incontri diretti tra obiettivo e sguardo. Come si è detto, la ricerca di un filtro è fonte simbolica del continuo slittamento dalla soggettività agli oggetti, dal mondo individuale a quello sociale e globale. Le strutture geometriche stesse, facendosi pattern astratti, rendono impersonale e omogeneo il mondo oltre cornice. E in questo sistema, gli uomini diventano presenze intercambiabili: consumatori e produttori di istanze sovraordinate. “I stand at a distance, like a person who comes from another world”9, sosteneva Andreas Gursky a proposito del proprio lavoro.
Tuttavia questo sguardo “alieno” a volte s’imbatte nelle anime. A volte compie il tentativo, per brevi istanti, di guardare gli uomini senza il loro complesso di oggetti o la loro pelle tecnologica e artificiale. Quando ciò accade la fotografia è suprema esibizione di un abisso, di una infinità pensosa, emozionale.
Nelle ultime immagini del volume, Luciana Galli mostra le mille solitudini degli umani e le silenziose tracce del loro passaggio. Questa volta lo spazio, alla stregua di un teatro che improvvisamente si svuota (Bari, 1979, Bari, 2016), torna a essere colto nel suo tempo posteriore, quello di un accaduto ormai dismesso. Un letto disfatto, uno sguardo assente, un uomo che dorme nel parco, una famiglia nello spazio indistinto di una spiaggia irlandese: sono tutti luoghi della distanza, terre emerse nella solitudine delle acque alte. Quando il rumore cala e il frastuono s’interrompe, quella lontananza di un obiettivo che cercava l’obiettività diventa lontananza emotiva, inaccessibilità che ci rende perfettamente simili alle cose, quando voltiamo loro le spalle.
Postilla. Per un proseguimento
Pochi giorni prima della stampa di questo volume, Luciana mi invia una fotografia scattata nel bel mezzo della spiaggia, tra i bagnanti, con l’acqua alle ginocchia. Si tratta di cinque donne, sui sessanta, in evidente sovrappeso. Sono in cerchio e la foto le coglie “da lontano”. Sono anch’esse icone pop della baresità ma anche, al contempo, di quella globalità fatta di colori ipertrofici e appariscenti. Tuttavia questa volta il distacco epistemico è un altro, meno palese; ed è il motivo dell’assenza di questa immagine dal presente libro. Luciana mi scrive: “Conservala. Forse tra cinquant’anni avrà lo stesso valore delle donne che giocano a bocce. Scene di vita a Pane e Pomodoro Beach”.
Ti rispondo qui, Luciana, con le parole di un artista che ha viaggiato e osservato tanto quanto te: “Le date, sai perché sono molto importanti? Perché se tu scrivi, ad esempio, su un muro 1970 sembra niente, ma fra 30 anni… Ogni giorno che passa questa data diventa più bella, è il tempo che lavora…” (Alighiero Boetti).
1 “XXXVIII Congresso dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici”, Roma 8-10 ottobre 2010.
2 P. L. Berger, T. Luckmann, La realtà come costruzione sociale, trad. it. Il Mulino, Bologna 1969.
3 E. Durkheim, Le regole del metodo sociologico. Sociologia e filosofia Ed. Comunità, Milano 1969.
4 R. Gaetano, Ad esempio a me piace il Sud, in Ingresso libero, IT, Roma 1974.
5 P. Marino, Festa di San Nicola, la fotografia mette Bari allo specchio del tempo, in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 2 aprile 2009.
6 A. Adler, Prassi e teoria della psicologia individuale, trad. it. Astrolabio Ubaldini, Roma 1978.
7 M. Parr, Common Sense, Dewi Lewis, Stockport 1999.
8 U. Eco, Kant e l’ornitorinco, Bompiani, Milano 1998.
9 A. Gursky, Concrete Reality, interview with C. Squiers, Ruhr Works, 1988.
La fotografia è scena nel clic di Luciana Galli. Dal bianconero al colore, storia di una vita d’artista
Pietro Marino su La Gazzetta del Mezzogiorno del 20.11.2016 . Recensione al libro Luciana Galli – Fotografie 1967-2016
Un mazzo di rose rosse posato sul bordo di un lavandino candido è l’immagine che Luciana Galli ha scelto per la copertina dl raffinato libro col quale propone una sintesi di mezzo secolo di vita con la fotografia. La foto è scattata a Cuba nel 2013 ma non ha alcun riferimento local: testimonia la più recente fase di un lavoro che ha puntato sempre a elaborare visioni del mondo. “Che ne pensi, è un po’ osée?” mi aveva chiesto lei nel darmi il volume, intitolato Luciana Galli. Fotografie 1967-2016 edito da Skira. Dubbio pudico, evidentemente infondato, per una fotografia che rimanda a una sorta di metafisica del quotidiano – in questo caso una poetica dell’abbandono, o dell’attesa – con misurata grazia di rapporti compositivi fra campi cromatici e sensi oggettuali. Conferma di un’attitudine al colore limpido e timbrico e alla scansione degli spazi in equilibri strutturali che ha sempre connotato la ricerca dell’artista barese. Scegliendo un “punto di osservazione a debita distanza, partecipe e discreto, seppure sempre allineato e assonometrico”, rileva Roberto Lacarbonara, autore di una presentazione attenta e problematica. Semmai accentuando negli ultimi anni un approccio all’immagine di tipo astrattivo-meditativo, in chiave di “pittura” come invenzione di forme sintetiche. Non a caso l’autrice cita come referenti solo due artisti – l’americano Hopper e l’inglese Hockney -nell’interessante conversazione con il curatore, in appendice del libro.
Il volume stesso è concepito in sostanza come un “libro d’artista”, a partire dal formato ad album. La sequenza delle 120 immagini estratte da un archivio di 15mila foto accenna sì per grandi linee a una cronologia dal 1967, l’anno in cui Luciana Galli laureata in legge, va a Londra per un mese di studio e comincia a fotografare “da turista” con una Zeiss Ikon regalata dal padre. Ma di fatto l’impaginazione procede per blocchi tematici, accostamenti visivi che tracciano andirivieni nel tempo, quasi a svolgere e riprendere fili d’attenzione fra momenti e ricerche diverse. Del talento dell’autodidatta è annuncio strepitoso la fotografia a colori scattata nel ’67 su un campo di bocce a Brighton: con due signore in bianco riprese di spalle con humour moltobritish. L’immagine sta a sé, in apertura di testo, quasi a segnare uno stacco netto dal primo gruppo di fotografie in bianconero. Evoca una fase ancora “realista” fra i Settanta e i primi Ottanta, scene di vita in Bari Vecchia e nelle campagne pugliesi con tagli alla Giacomelli. Luciana frequentava il gruppo dell’Art Director Club in Bari Vecchia, primo tentativo di consociazione fra operatori della visione moderna che lei abbandonò presto, compiendo una scelta di esperienza in solitario, ai margini delle mischie e delle aggregazioni locali.
Già una foto del 1978 che inquadra un vano o edicola in Bari Vecchia – dove le immaginette di San Nicola e della Madonna sono confuse con quelle di dame e di dive – dichiara l’attrazione per il popular come anticamera del pop urbano. Emerge una idea di fotografia come “scena” sulla quale agiscono “non persone ma personaggi” (annota acutamente Lacarbonara) – pellegrini delle feste di San Nicola o passanti in città. Oppure gli oggetti, specie se abbandonati dal consumo di massa (come i “Rifiuti e no” della personale 1985 in Santa Scolastica). O gli accostamenti fra “geometrie colorate e metalliche”, si tratti di edicole, bus, o di cancellate, palizzate, griglie di edifici. Certo, una parte importante di foto è tratta dai numerosi viaggi all’estero – da Yalta 1972 a New York, da Berlino a Dubai, dagli Emirati Arabi all’Irlanda. Ma non è fotografia on the road, la ricerca di fermo-immagini sui “luoghi comuni” di una società che si dà attraverso finzioni mediatiche e svuotamenti di vita.
Tema della simulazione che l’autrice ha incrementato con l’uso sistematico – pionieristico per Bari – delle tecniche digitali sia nei cromatismi sia nei collages elettronici (esemplari le foto di Berlino 2008 e Doha 2013). Sarebbe stato più evidente se non avesse espunto dal libro le folte serie di sperimentazioni d’immagini moltiplicate da dissezioni, ribaltamenti, rispecchiamenti, una ricerca forse ritenuta osée. Peraltro non sono enfatizzati, all’estremo opposto, nemmeno i cicli “professionali”: come i documentari di città con le architetture e i luoghi rilevanti, il Petruzzelli prima e dopo l’incendio. Specie per Bari, produzioni preziose per il turismo culturale. Ne lampeggiano alcuni estratti visionari, come le due fotografie in bianconero di rovine interne del Petruzzelli nel 1992. Annunciano il velo di distesa malinconia, l’ombra del tempo che si allunga sulle visioni mature di Luciana Galli. Come l’immagine da lei molto amata del letto bianco disfatto che si staglia in un vuoto nero tagliato da una quinta rossa, sentimento nascosto sotto il titolo archivistico “Castel di Tusa, 2007”.
Fotografia/Il personaggio
Il mondo di Galli
Antonio Di Giacomo, la Repubblica, 8 novembre 2016. Recensione al libro Luciana Galli – Fotografie 1967-2016
L’editore Skira celebra i cinquant’anni dietro l’obiettivo della fotografa barese con un libro. Nella monografia curata da Roberto Lacarbonara un percorso attraverso 120 immagini.
E’ la testimonianza di uno sguardo sul mondo attraverso mezzo secolo di fotografia. Sono i cinquant’anni di un ininterrotto ma ragionato scrutare della fotografa barese Luciana Galli racchiusi nella monografia Luciana Galli – Fotografie 1967-2016, appena pubblicata da Skira (pp.176, 56 euro). Dietro le quinte la cura di Roberto Lacarbonara, docente all’Accademia di belle arti di Lecce, e il photo editing di Alessandro Cirillo ad attendere il lettore che sfoglierà e risfoglierà questo volume. C’è un grande album di 120 immagini, la quasi totalità delle quali, ben 101, a colori. Si tratta di una sintesi, di una sorta di possibile estratto da un archivio di 15mila fotografie scattate da Galli nel corso della sua vita, divisa tra il mestiere di docente di Diritto e la passione totalizzante per la fotografia. Un’avventura iniziata, confida l’autrice, “quando nel 1967 partii alla volta dell’Inghilterra per una vacanza di studio insieme a una Zeiss Ikon, una macchina fotografica a telemetro che mi era stata appena regalata da mio padre”.
E fin dai primissimi scatti appare evidente, sebbene ancora in embrione, l’essenza dello sguardo di Luciana Galli, come testimonia l scena catturata nel verde di un parco a Brighton: due eleganti signore biancovestite riprese di spalle durante una partita a bocce.
L’allora giovanissima fotografa, infatti, colloca le sagome delle due figure femminili nel loro dialogo con lo spazio circostante. Non un raccontare in via diretta l’uomo. Lontana così dall’interesse per la ritrattistica o per la fotografia di reportage, se non in qualche occasionale incursione, pure documentata en passant nel volume, la curiosità della fotografa è volta alla narrazione delle architetture, dai cortocircuiti estetici all’interno delle città, e non solo, e, più in generale, dei segni del passaggio dell’uomo. Sicché l’eventuale presenza della figura umana nelle fotografie di Galli risulta funzionale al più ampio disegno di raccontare i paesaggi urbani o naturali nella loro totalità, ovvero nel loro tessuto di relazioni con gli uomini. “ Luciana Galli documenta contesti urbani e linguaggi estetici – scrive il curatore Lacarbonara – di società molto differenti e distanti, dagli Stati Uniti agli Emirati Arabi, da Cuba ai Balcani, dalla Russia alla propria terra, Bari. Cogliendo sia gli stereotipi culturali sia la progressiva, rapida omologazione del sapere, del gusto e, talvolta, del cattivo gusto all’interno delle metropoli moderne, l’autrice attraversa la sfera dell’ordinario e del trash al fine di raccontare quel vivere quotidiano che rivela il paradosso dell’orribile ma rassicurante familiarità”.
In tema di affinità elettive, poi, osserva ancora Lacarbonara “la grande passione verso Edward Hopper, la matrice americana del colore di William Eggleston e Stephen Shore, insieme a un singolarissimo interesse verso tutti quei fenomeni di convivenza tra realtà e simulazione (dove gli apparati pubblicitari prendono il sopravvento sulle superfici degli spazi pubblici) rendono la fotografia di Galli radicalmente innovativa “ .
Ma a prevalere su tutto, assicura l’autrice, “c’è stato il mio insopprimibile bisogno di fotografare e raccontare quanto incontrava il mio sguardo. E’ stato, ed è, il mio modo di stare al mondo”.
ALL’ULTIMO RIGO
La lettura del lunedì/2
Giusi Alessandra Falco su Vedo Rosa, blog del Corriere del Mezzogiorno, 24 novembre 2012
Non lasciatevi ingannare dalle prime pagine, non chiamatelo subito thriller, o romanzo giallo, o polar. Aspettate. Perché non è solo questo. Potremmo iniziare col dire che “All’ultimo rigo” è un romanzo che attinge ad una vicenda privata, alle storie incrociate di una famiglia come tante. Il dettaglio? Il protagonista, Kámil, lo conosciamo già: l’avevamo incontrato nel primo romanzo della Galli, “Fuorigioco”, nei panni di un detective per caso. La vicenda al centro del romanzo, invece, non è una sola, ma ne contiene diverse altre: in questo senso, “All’ultimo rigo” è una sorta di romanzo-scatola, un romanzo a più strati, in cui succede qualcosa ad ogni livello della storia. È per questo che vi dicevo di non chiamarlo romanzo giallo. Perché non lo è. O, perlomeno, non è solo questo: è tanti romanzi.
E visto che a molti piacciono le definizioni, vediamo insieme di quali romanzi si tratta.
. Romanzo giallo, o, forse, potremmo chiamarlo thriller: eccovi accontentati. Perché c’è una forte tensione, tra le pagine, perché l’autrice crea sospensione e i suoi personaggi riescono a rigirare al lettore le domande che essi stessi si pongono.
. (Mini) Saga familiare. Assieme a “Fuorigioco”, dicevamo, questo romanzo segue la storia di una famiglia, nel tempo, raccontandola da diversi punti di vista e creando, ogni volta, contesti diversi. Vediamo crescere e cambiare i personaggi, vediamo le vicende modellarsi a loro misura. (Questo, tra l’altro, crea un po’ quell’effetto di attesa che mi fa pensare alle serie tv: fidelizzazione ed identificazione).
. Romanzo psicologico. Come scrive Pasquale Bellini in quarta di copertina, “All’ultimo rigo” è paragonabile ad una seduta d’analisi. Ed è vero: i personaggi, in questa storia, assumono, di volta in volta, il ruolo di ascoltatori e di ascoltanti, e cercano di capire cosa succede agli altri. Cercano di accedere all’intimità degli altri.
. Infine, “All’ultimo rigo” contiene diverse riflessioni sull’arte, sul rapporto tra l’arte e il corpo, sulle reazioni fisiche che l’arte può scatenare negli uomini. E, leggendo, capirete che questo è uno dei nodi fondamentali del romanzo della Galli. Le opere d’arte diventando veri e propri personaggi.
Ora: tutte queste definizioni sono vere ed utilizzabili; ma solo in parte. Perché “All’ultimo rigo” è, in realtà, un romanzo che spiega bene la complessità delle vicende umane – anche di quelle che appaiono semplicissime. Con una scrittura sospesa e volta all’azione, più che alla descrizione, Luciana Galli ci consegna un (altro) romanzo aperto, che non giunge ad una conclusione netta, e che mostra la libertà di raccontare, di fermarsi ad un certo punto, di mostrare scene come se fossero fotografie. Di fermarsi ancora, anche lasciando tutto in sospeso. Senza mai forzare il piacere della narrazione.
Parole e immagini per raccontare in noir
Giusi Alessandra Falco, estratto dal Corrriere del Mezzogiorno, 30 settembre 2012
Il romanzo della Galli, corredato da una serie di fotografie, continua a sviluppare la traccia di un moderno giallo psicologico. Se, da un lato, il testo è scandito da un ritmo serrato come quello di un serial televisivo americano, dall’altro si delinea il profilo analitico della scrittura della Galli che si vuole introspettiva, ma con leggerezza, e che sa mostrare, attraverso la finzione, le contraddizioni quotidiane.
Il mistero finisce all’ultimo rigo
Enrica Simonetti, estratto da La Gazzetta del Mezzogiorno del 2 ottobre 2012
Se si trattasse di un film, diremmo che questo è un sequel del precedente. All’ultimo rigo, il nuovo romanzo scritto dalla fotografa Luciana Galli è la continuazione di Fuorigioco, ma senza che la lettura dell’uno sia forzatamente legata all’altro libro. In realtà l’autrice segue la storia del thriller precedente, facendo vivere agli stessi protagonisti una nuova avventura, anche questa ambientata in un paese immaginario della Sicilia, anche questa legata alle implicazioni psicologiche che certe esperienze della vita ci fanno affrontare. E così, come se passassimo da una seduta di psicanalisi alla poltrona di un cinema, ci troviamo a seguire un’avventura in cui ci sono legami familiari e di coppia, ma anche macchie di sangue, misteri e opere d’arte… Il linguaggio semplice permette una lettura rapida e avvincente. Come nelle sue immagini, Luciana Galli lascia a chi guarda (e a chi legge) la voglia di scoprire …
All’ultimo rigo è da BLUorG
Antonella Marino, estratto da La Repubblica, Bari , 6 ottobre 2012
Storie s’intrecciano qui con un ritmo giallistico dai risvolti psicoanalitici e una scrittura lucida e visiva che con incastri di fotogrammi costruisce una trama misteriosa e avvincente dal finale aperto. Metafora dell’impossibilità di conoscere il reale nella sua totalità e da un unico punto di vista? Di certo nel racconto – che si snoda tra Berlino e la Sicilia fra rigore apparente ed emotività rimossa – si coglie lo stesso gusto per l’indagine e l’osservazione dei dettagli che la Galli sviluppa anche nelle sue fotografie: come confermano anche i ventidue scatti che arricchiscono il testo.
All’ultimo rigo intrigo e mistero
Caterina Rinaldo, estratto da Barilive, giornale telematico della Città di Bari, 14 ottobre 2012.
Il nuovo romanzo nero di Luciana Galli conquista la platea. Un susseguirsi di immagini elegantemente composte, accompagna la narrazione che unisce luoghi distanti e immaginari, evoca sensazioni di angoscia e terrore, tesse sottili trame che si alternano a cambi di scena dove gli indizi sono disseminati, dissimulati, apparentemente nascosti, a volte, apertamente rivelati. Nella loro autentica semplicità, esse sono simboliche, a tratti allusive, in costante avvicendamento con lo svolgimento della narrazione.
La trama: Kámil Demir il protagonista buono di Fuorigioco è ormai a conoscenza dei dettagli dell’assassinio verificatosi nell’abitazione da poco acquistata, ma decide di non rivelare la sua scoperta. Questo terribile segreto lo porterà a sviluppare un’ossessione nervosa, al punto che la moglie Cristine sarà costretta a chiedere l’intervento di uno psichiatra, il tormentato Markus Winkler che, a sua volta, cela un passato misterioso: la morte della sua compagna Sophie avvenuta in circostanze tutte da chiarire.
I personaggi: il primo è Kamil Demir, l’informatico turco di religione islamica coinvolto nella scoperta dell’assassinio del giornalista Walter Russo. E’ ossessionato dalle macchie di sangue generate sulle pareti della sua abitazione dalla raffica di proiettili con cui è stato ucciso il giornalista. E’ un uomo sostanzialmente terrorizzato. Il secondo personaggio è Markus Winkler, lo psichiatra incaricato di curare le ossessioni di Kámil. In realtà il medico diventerà il malato e il malato si tramuterà in colui che si occuperà del medico. Winkler ha un passato segreto e Kamil riuscirà a farlo emergere.
Le fotografie dei luoghi sono tratte dai viaggi compiuti dalla scrittrice-fotografa dalla Sicilia a Berlino. Creano un percorso dinamico e ricco di scenari di volta in volta diversi il cui valore è legato ai protagonisti ed ai personaggi che sono speculari, entrambi ossessionati da qualcosa: il primo dal sangue, il secondo dalla bellezza. Kámil vede affiorare le macchie di sangue sulle pareti appena imbiancate, Winkler si sente male di fronte all’altare di Pergamo. Egli cerca con la bellezza di guarire ciò che ha dentro, ma questo tentativo fallirà.
FUORIGIOCO
Un detective (e una scrittrice) per caso
La fotografa d’arte Luciana Galli si misura con un thriller avvincente e pieno di colpi di scena
Giusi Alessandra Falco sul Corriere del Mezzogiorno, 6 aprile 2012
Lo chiamano “genere poliziesco” e la sua definizione rimanda immediatamente a storie di detective, commissari di polizia e casi da risolvere. Eppure, fra i protagonisti del genere, esistono nomi, noti al grande pubblico, di dilettanti: si pensi all’impicciona e perspicace Miss Marple, che appassiona ancora i lettori dei gialli di Agata Christie. Per non parlare di Castle, scrittore di best seller e detective improvvisato, scelto come protagonista di una nota serie televisiva. Sarà forse perché è più semplice identificarsi con un “supereroe per caso”, o sarà che i detective non professionisti, nelle finzioni,riescono spesso a cavarsela meglio degli altri. Il dato di fatto è che continuano a incuriosire e a godere di buona fama, tra i lettori e tra gli spettatori. Sembra saperlo bene anche Luciana Galli, fotografa d’arte, insegnante di diritto e scrittrice per passione, che ha appena pubblicato il thriller fuorigioco. Un romanzo il cui protagonista è proprio un detective dilettante, per caso e per necessità, che della ricerca della verità del “suo” caso sembra farne una ragione di vita, anche se solo nello spazio di qualche giorno. Il motivo? Puramente culturale. Religioso, per la precisione, e così importante da andare a scomodare il passato di un giornalista assassinato, la vita di un intero condominio e i codici cifrati di Giulio Cesare. Servendosi di uno scenario irreale, talvolta al limite dell’inverosimile, e ricco di dettagli – il volume include anche una serie di foto scattate dalla Galli – la scrittrice barese costruisce una narrazione serrata, ricca di colpi di scena e, in sole 135 pagine, riesce a delineare il sistema di “racconto nel racconto”, schema ricorrente nel romanzo giallo. Le descrizioni, che rivelano lo sguardo da fotografa della Galli, sono talmente accurate da far quasi dimenticare al lettore che si tratta di finzione, mentre la scrittura si sofferma spesso su immagini precise, su profili di personaggi la cui storia passata si può intuire dai gesti, dai vezzi o dal colore sintetico dei capelli. E’ una scrittura figurativa, quella della Galli, ma anche d’azione, che si serve di un’ironia appena accennata per stemperare i toni grevi dell’omicidio da ricostruire, e che, attraverso l’uso della prima persona, avvicina ancora di più l’emotività del protagonista a quella dei lettori, suscitando curiosità. Ed è forse proprio la curiosità, il motore narrativo di questo thriller, è l’interesse per la vita privata di uno sconosciuto a far sì che la storia vada avanti. Fuorigioco è un romanzo in cui è il lettore stesso a sentirsi coinvolto nell’indagine e a partecipare al lavoro d’inchiesta. Viene posto di fronte ad enigmi irrisolti e a passi di romanzi stranieri in lingua originale. Da comprendere perché potrebbero essere la chiave. O forse no, ma non importa: basta provarci, in tutti i modi. Perché la vita degli altri, per un detective per caso, può essere molto interessante. Almeno quanto un romanzo giallo.
Se la storia noir comincia per “K”. Luciana Galli, dalla fotografia al thriller
Enrica Simonetti su La Gazzetta del Mezzogiorno, 3 aprile 2012.
Le case posseggono le impronte delle persone che le hanno abitate, conoscono le loro ombre, seguono silenziosamente i loro segreti. Luciana Galli, conosciuta come fotografa, esordisce nel mondo della scrittura con un thriller dal titolo Fuorigioco, che ci fa viaggiare dal cassetto di una casa ad un giallo internazionale. Un viaggio in cui non ci si annoia mai perché i colpi di scena si susseguono, tra coincidenze, personaggi ambigui e storie di corruzione che s’incrociano tra loro senza apparenti connessioni. La storia parte appunto da una casa. Kámil Demir è un esperto di informatica del Cnr, di origine turca, che da tempo vive in Italia e che si trova a cercare una residenza in un paese siciliano (immaginario), San Giuliano di Leofante. Si rivolge ad un’agenzia immobiliare e da Milano giunge in un vecchio palazzo nobiliare, ma soprattutto giunge in una matassa che sconvolgerà la sua esistenza. Lui, figlio di immigrati imprenditori da decenni nel mondo delle saune e degli hammam non è più solo un uomo di successo, di fede islamica, con una moglie berlinese e alla ricerca di una bella casa. Perché all’improvviso,, aprendo un cassetto di un vecchio mobile abbandonato in questa abitazione, si trova a decifrare misteri, a indagare su una lettera, “k”, che per un po’ lo fa esplorare nel mondo letterario: Kipling, Kafka, Rilke… una caccia al tesoro, che si svolge in un’atmosfera surreale, capace di spostare l’attenzione da alcune pagine poetiche ad un tappeto per la preghiera, per poi farci ancora finire in un delitto e poco dopo a indagare su una password. Non si può dire di più per non togliere freschezza alla lettura del romanzo. Tutto si condensa: fatti e immagini, personaggi e misteri. Lo stile è asciutto, come spetta ad un thriller. Ma Luciana Galli non riesce a celare la sua vera identità di fotografa: riesce, con le parole e non più con il suo zoom, a descrivere le scene, a dipingere i fatti, facendoci immaginare il protagonista, la sua barba folta, i suoi capelli, il fisico asciutto, la voglia di guardare oltre. E, siccome – lo dicono i grandi fotografi – non basta la macchina per scattare buone immagini, ma serve l’occhio, è la vista dell’autrice a portarci lontano.
Fuorigioco, il noir di Luciana Galli
In libreria l’opera prima della fotografa barese. Un thriller immerso nel malaffare del Mezzogiorno.
Antonio Di Giacomo su La Repubblica, 27 marzo 2012.
Quel che si direbbe un esordio tardivo. Ma l’autrice, Luciana Galli, ha dalla sua una buona scusa: finora, in effetti, non ha fatto altro, o quasi, che fotografare. E come tale, a conti fatti, è nota nella sua Bari. Finché lo scorso 5 marzo non ha dato alle stampe il suo romanzo d’esordio, senza rinunciare tuttavia al racconto per immagini: è il noir fuorigioco, (pp.144, 12 euro), dove la narrazione è contrappuntata da una sorta di diario fotografico in bianco e nero, firmato naturalmente dalla stessa Galli. “Non è un libro che avevo, come si suol dire, riposto nel cassetto – avverte l’autrice – ma una storia che ho scritto di getto, avvertendone un’inattesa urgenza”. La vicenda è ambientata a San Giuliano di Leofante, un paese inesistente che Galli immagina immerso nell’entroterra siciliano. E’ qui che un informatico di origine turca, e fede islamica, si trasferisce per lavoro, ritrovandosi suo malgrado a diventare un detective per caso, alle prese con un omicidio avvenuto quindici anni prima. Ma da cosa è scaturita la voglia di provarsi scrittrice e non più soltanto fotografa? “Stavo rileggendo Il Processo di Kafka, quando dinanzi allo smarrimento di Joseph K.- svela Galli – ho sognato di tuffarmi in una storia che è poi un labirinto di corruzione e di malaffare dei giorni nostri”. Finché il sogno non si è fatto libro.
Dalla fotografia al giallo
Caterina Rinaldo su Barilive, giornale telematico della Città di Bari, 16 aprile 2012
A volte le cose non sono come appaiono. Lo sa bene la fotografa Luciana Galli che per anni ha indagato la realtà, svelando e scoprendo aspetti nascosti, coniugando ricerca e sperimentazione, fotografando e ri-foto(grafando) città e territori, paesaggi ed architetture, ricercando tracce e segni a volte invisibili, a volte solo nascosti. Autrice poliedrica, attenta alle novità, eclettica come solo i veri artisti sanno essere, sperimenta repentini cambi di rotta e rifiuta di essere chiusa in una definizione. del Comune di Bari. Un lavoro straordinario quest’ultimo, che associa alla sua formazione giuridica la sensibilità dell’artista. Ha condotto ricerche sul paesaggio urbano e sull’architettura moderna. E sarà per questo motivo o forse per il gusto di raccontare e far scoprire tramite le parole (oltre che con le immagini), che ha deciso di cimentarsi anche con la scrittura, pubblicando il romanzo giallo dal titolo Fuorigioco, ambientato a San Giuliano di Leofante, un paese immaginario della Sicilia. Qui Kámil Demir, un informatico del CNR, trasferitosi da Milano nel piccolo paese dell’entroterra siciliano, non immagina quali segreti si celino nella sua nuova abitazione. Mettendo in relazione segnali e indizi, giungerà ad indagare in modo del tutto casuale su una vicenda misteriosa, avvenuta molto tempo prima proprio in quello stesso appartamento. Una vicenda di cui nessuno parla. “Chi non guarda molte cose, non pensa molte cose”, suggerisce un detto. Ma chi ha osservato a lungo la realtà, indagando e scoprendo verità nascoste, è in grado di raccontarla così come, adoperando la macchina fotografica, riesce a mostrare l’inaspettato. E del resto “Le case nei cassetti dei loro arredi, nascondono sempre un’impronta delle persone che le hanno abitate e le loro storie segrete”, recita un brano del romanzo. Così l’autrice descrive dettagliatamente in questo giallo leggermente noir, riferimenti utili per la soluzione del mistero. Non resta che saper cercare dunque. Quale segreto si nasconde nell’abitazione? Come rivelarlo? La risposta è celata dietro agli indizi, dietro le tracce disseminate all’interno dell’appartamento, che il protagonista seguirà poco per volta per giungere alla soluzione finale della vicenda. Il libro inoltre è arricchito da diciannove fotografie dell’artista di straordinaria realizzazione. Con queste immagini, l’autrice apre finestre reali sull’immaginario racconto, crea collegamenti con la storia narrata, aggiunge sapienti dettagli.
SAN NICOLA DI BARI E DI MYRA
Cronaca di una Festa di Maggio. Festa di San Nicola, la fotografia mette Bari allo specchio del tempo.
Pietro Marino su La Gazzetta del Mezzogiorno, 2 aprile 2009.
Chissà se al Trap e ai dirigenti calcistici dell’Irlanda gliel’ha dato, il sindaco Emiliano. Dovrebbe essere così, perché in funzione di ospiti e turisti eccellenti è stato pensato. Sto parlando di un elegante libriccino su San Nicola di Bari e di Myra, sottotitolo Cronaca di una Festa di Maggio. E’ stato prodotto per il Comune di Bari (sponsor la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia) da Luciana Galli, la nota fotografa barese: suo è il progetto e sue le fotografie che sostanziano la pubblicazione. Il tema è quello annunciato: origini della festa, sin dalla “sacra rapina” di Myra, e sviluppi e caratteristiche nel tempo, in una dimensione di grande interesse antropologico, che svaria dalla fede agli affari. Secondo la tradizione barese, sicché ben dice il sindaco Emiliano nella paginetta d’ introduzione che “è un po’ come guardare la città di Bari nello specchio del tempo”. E’ molto significativa la struttura iconografica. Perché offre la sintesi di un lavoro trentennale di ricerca sul campo compiuta da Luciana Galli. Con la limpidezza di luce e l’esattezza di inquadratura che sono caratteristiche della sua fotografia. Quanto meno, nei temi per i quali privilegia un realismo di narrazione che sfugge alle forzature estetizzanti. Semmai tiene in sottofondo o controcanto la cordialità affettuosa dell’attenzione per l’umanità quotidiana che nella festa si esalta. In continuità storica, come segnalano le due foto del mitico panificatore di Bari vecchia che esibisce la formella di San Nicola “scolpita” nel pane: sono pressoché identiche, solo che la prima è stata scattata nel 1983, la seconda nel 2008, e il passaggio del tempo è segnato solo sul volto degli uomini. Affettuosità di sguardo che ritaglia in campo lungo le scene di pellegrinaggio a mare (ma c’è un’inquadratura di siesta di pellegrini sotto gli alberi, 1976, che sa di Grande Jatte, il celebre quadro di Seurat). Mentre indugia, stringendo i primi piani, sulla fascinazione iconica delle bancarelle, fra statuine di San Nicola (1987) e Marilyn (1977). Con un’impennata visionaria: quella dei velari bianchi tesi sulla facciata della Basilica di San Nicola da Luca Ronconi nel 1987. Una delle rare occasioni in cui il corteo storico inventato dal “Maggio di Bari” nel 1951 come ribalta turistica della festa popolare provò ad uscire dalla sua crisi d’identità e di idee.
Trent’anni di devozione in scatti d’autore
Antonio Di Giacomo su La Repubblica, 12 aprile 2009.
Un volume della fotografa barese Luciana Galli dedicato a San Nicola Trent’anni di devozione popolare e, nel suo specchio, la storia di una città. A raccontare la vicenda provvedono le immagini della fotografa barese Luciana Galli che, dal 1976 al 2008, ha documentato con l’obiettivo della sua reflex la festa nicolaiana di maggio in maniera tutt’altro che didascalica. Una cinquantina di immagini, fra le migliaia catturate negli anni dalla Galli, sono ora raccolte nell’album San Nicola di Bari e di Myra (cronaca di una Festa di Maggio), dato alle stampe dal Comune di Bari con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia. Fra le pagine le fotografie della stessa Galli, interpolate con testi del giornalista Tito Manlio Altomare. Cinque gli eloquenti titoli per le altrettante sezioni del volume: tre navi partirono da Bari…, iconografia di San Nicola, la processione a terra (gens peregrina), Sanda N’col va p’mar e Festa Fede Affari. A dominare in questo racconto fotografico della Galli è un’impronta di marcato realismo, che affiora ora nelle testimonianze della ritualità di ieri, ora nella festa ormai globalizzata. Nel mezzo resiste a fatica, ma resiste, il senso della tradizione: a dimostrarlo proprio due scatti della Galli che, a venticinque anni di distanza l’uno dall’altro, raffigurano l’immagine di San Nicola nelle formelle di pane realizzate nella città vecchia.